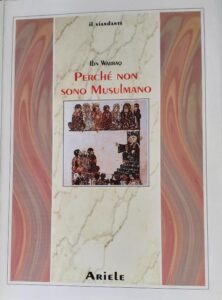
Due premesse.
Ibn Warraq è uno pseudonimo perché l’autore, di cui si hanno pochi elementi biografici, è oggetto di minaccia da parte dell’Islam perché ha abbandonato la religione e perché critico dell’Islam.
Il titolo non è né strano né provocatorio; esso richiama alla mente il celebre “Perché non sono cristiano” di B. Russell del 1927 che ha portato anche alla pubblicazione di numerosi testi dal titolo simile.
Il libro è diviso in 17 capitoli che coprono tutti gli aspetti legati alla religione islamica, sia teorici sia storici e si basa su una ricchissima bibliografia di studiosi dell’argomento, compresi religiosi e poeti di fede islamica. Esso trae spunto dalla Fatwa, con conseguente condanna a morte per blasfemia, nei confronti dello scrittore Salman Rushdie del 1989. In seguito a questa condanna lo scrittore ha dovuto vivere nascosto perché qualsiasi musulmano avrebbe potuto compiere la condanna a morte.
La storia di condanne a morte ed esplosioni di rabbia nei confronti di chi critica l’Islam non ha avuto interruzioni dal 1280 ai giorni nostri, visto che la critica corrispondeva immediatamente all’accusa di eresia con la conseguente pena di crocifissione, decapitazione o rogo. Ma anche i riformatori, coloro cioè che proponevano un cambiamento erano oggetto di condanna. E questo è il grosso problema del dialogo con l’Islam, visto che si presenta come una religione chiusa e monolitica. Anche l’apostasia, cioè l’abbandono della religione islamica, è oggetto di condanna.
Da un punto di vista storico naturalmente emerge la figura di Maometto a cui vengono dedicati un paio di capitoli e del profeta vengono presentati i diversi lati che emergono dalle notizie a noi note. Da un lato la sua figura è stata presentata in mille modi: sorriso, fascino, carisma, capo militare, uomo di stato, ma fu anche una persona ambigua, pronto a mantenere la parola data e a rinnegarla, quando la ragion di stato lo richiedeva. Per questo motivo non c’è da meravigliarsi se fu autore di molte atrocità: “Muir riassume alcune delle atrocità riportate, è importante ricordarlo, da impeccabili autorità musulmane quali Ibn Ishaq e Al-Tabari” e tutto ruotava intorno alla disponibilità a sottostare al suo potere (pag. 345).
In realtà Maometto riuscì a formare una comunità cementando tribù e realtà estremamente diversificate e conflittuali. E non esitò a spargere sangue per garantirsi il potere a tal punto che nella storia islamica la necessità di uccidere i nemici dichiarata da Maometto servì da pretesto a molti potenti islamici per giustificare le loro uccisioni: e questo è avvenuto nel corso dei secoli fino alla fatwa di Khomeini contro lo scrittore Salman Rushdie.
Come ha scritto il celebre islamista Margoliouth: “Il costante spargimento di sangue che caratterizzò la sua carriera a Medina sembra aver inculcato nei suoi seguaci una profonda fede nel valore dello spargimento di sangue come mezzo per far aprire le porte del Paradiso” (pag. 345).
Il successo di Maometto fu reso possibile dalle sue capacità politiche e militari unite alla predicazione di una fede religiosa, in parte ripresa dall’ebraismo e dal cristianesimo, più vasta e complessiva rispetto alle locali religioni pagane.
Corano e Maometto sono indissolubili e ogni buon musulmano dice quello che ha studiato convinto che sia la Verità. Da un punto di vista storiografico esiste comunque un problema legato alle fonti, perché del Corano si ha notizia solo a partire dal 923 d.C. quindi ben 300 anni dopo la morte del profeta (632 d.C.), le cui prime biografie risalgono comunque a più di un secolo dopo la sua morte (768 d. C.).
Gli hadith poi che completano il Corano rappresentano una tradizione di valore giuridico e religioso, che fanno riferimento in genere alla vita e alle opere del profeta, ma essi compaiono solo a partire dall’ 870 d.C.
Molti poi sono i dubbi sulla loro autenticità, anche per la diffusa mancanza di testimonianze; molti gli studiosi e molte le interpretazioni, soprattutto all’interno del mondo islamico, frutto anche di lotte di potere: pensiamo a questo proposito alla più grande spaccatura dentro l’Islam, quella tra Sciiti e Sunniti.
Per quanto riguarda il Corano l’autore ricorda come un grande studioso musulmano vissuto alla fine del 1400, Al-Suyuti, abbia illustrato come almeno cinque passi del Testo Sacro non possono essere la voce di Dio, oltre alla presenza di numerosi termini non arabi. Ci sono poi diverse versioni che possono dare origine a diverse interpretazioni e sempre al Suyuti nota che molti versi hanno abrogato altri versi, talvolta più recenti. Molti episodi e personaggi della Bibbia trovano il loro posto nel Corano visti in senso letterale e in questo senso il Testo Sacro si presenta non solo come un messaggio spirituale ma soprattutto come una visione complessiva del mondo tanto che persino le scoperte scientifiche degli ultimi secoli troverebbero una loro anticipazione nel Corano.
Alcuni capitoli sono poi dedicati al tema della democrazia per le sue difficoltà a realizzarsi nel mondo islamico (La natura totalitaria dell’islam. L’islam e’ compatibile con la democrazia e i diritti umani?). Su questo aspetto l’autore ritiene che l’Islam non possa staccarsi dalle sue radici totalitarie semplicemente finché il Corano e la Sharia verranno considerati come Leggi divine da avere sempre e comunque il sopravvento sulla vita degli uomini.
Due capitoli parlano di storia, storia araba e colonialismo islamico, storia fatta di violenza, guerre, saccheggi, schiavitù, commercio degli schiavi, razzismo arabo nei confronti di tutti i non-arabi e in particolare di ebrei e neri, imperialismo islamico che ha coinvolto il mondo arabo, quello persiano, quello indiano, con enormi discriminazioni e violenze religiose. Elementi che non sfuggono alla storia di nessun popolo e di nessuna civiltà, con la differenza che nel mondo islamico da un lato non si può discutere quegli eventi, perché l’umano è sempre mescolato al religioso, e dall’altro la difficoltà a convivere con altri popoli e altre religioni si manifesta tuttora nel XXI secolo. Basta vedere a come si è ridotta (quasi a zero) la presenza ebraica nei paesi arabi, un tempo numerosa, agli episodi di violenza subita dalla comunità cristiana in Pakistan, nelle Filippine, in Nigeria e anche in Egitto.
Ampio spazio è poi dedicato alla cultura islamica, di cui viene rilevata l’adesione al dogma religioso che ha trasformato liberi pensatori in eretici, mentre al di là di Avicenna e Averroè, influenzati dalla filosofia greca, il panorama del pensiero islamico riconduce sempre al tema religioso, cosa che ha impedito un significativo contributo nel campo della ricerca e dello sviluppo scientifici.
Interessante è anche il capitolo sulle donne, che, basandosi sul Corano, rinvia all’ambiguità del Testo Sacro già evidenziata in precedenza.
Al di là delle discussioni interminabili su cosa dice il Corano risulta interessante il pensiero di una nota femminista egiziana, che tanto ha fatto per le donne del suo paese, Nawal el Saadawi; per lei c’è stata “una regressione della donna araba dai tempi di Maometto e rispetto allo spirito dell’Islam”.
Non potevano mancare capitoli su quei tabù che conosciamo bene, il vino, la carne di maiale, l’omosessualità.
Il vino viene esaltato da Maometto ma poi condannato perché i suoi compagni di si ubriacavano facilmente e si allontanavano dai compiti prescritti; ma poiché il Profeta non è un pensatore sistematico è inutile cercare un insieme coerente di princìpi nel Corano (vedi la recensione al libro di Abdel Samad). Poeti islamici hanno spesso tessuto le lodi del vino, per non parlare di quanto l’alcol scorra a fiumi nel segreto delle case islamiche, ma questo è un fenomeno comune a tutte le proibizioni.
Per la carne di maiale è opportuno ricollegarsi a pratiche precedenti sia pagane sia religiose e le motivazioni che i più colti danno, animali sudici e causa di malattie, sono improponibili perché quella è la caratteristica di molti altri animali la cui carne non è proibita.
Per quanto riguarda l’omosessualità in passato ci fu molta più tolleranza rispetto ad altre comunità, tolleranza che è ormai un pallido ricordo visto che oggi in alcuni paesi islamici è prevista la condanna a morte. Eppure sappiamo bene quanto essa sia diffusa anche in relazione alla separazione netta tra maschi e femmine.
In generale questi tre tabù non hanno particolare significato religioso ma ci aiutano a capire alcuni aspetti tipici dell’universo islamico:
1)La gente comune risponde a chi gli chiede il perché con la più semplice delle risposte “Lo dice il Corano”, dimostrando quanto poco sia il livello di conoscenza del testo e soprattutto quanto sia impossibile una riflessione critica dello stesso.
2)Col passare del tempo certe pratiche che rispondevano a esigenze quotidiane in un contesto poco alfabetizzato hanno cambiato prospettiva: sono diventate parte di un Credo con cui identificare il “Noi” e isolare “Gli altri”.
3)La mancanza di libertà, di democrazia, il perdurare di valori che in tutto il mondo (anche non occidentale come Giappone, Cina, India, Africa cristiana) sono almeno messi in discussione fa sì che quei tabù divengano occasione di identità e scontro ideologici.
Il libro termina con una riflessione sull’Islam in Occidente, una riflessione ampia che illustra il carattere estremamente variegato e molto ricco del mondo islamico in Occidente. La presenza di nuclei fondamentalisti e terroristi è sotto gli occhi di tutti, come pure gli attacchi mirati contro le comunità ebraiche. Questo non vuol dire che tutti coloro che sono di fede musulmana siano sostenitori di queste derive, ma è certo che troppo spesso le autorità hanno chiuso un occhio per non cadere nell’accusa di quella barbara e curiosa nozione che è l’islamofobia.
La discussione è aperta e rimane il nodo di come integrare in stati liberaldemocratici, stati di diritto, comunità che rivendicano un’alterità che non è religiosa, ma che in base alla religione pretende di imporre eversive pratiche civili.
Se da un lato personalità come il Sindaco di Londra, l’islamico Sadiq Khan, sono perfettamente integrate ci sono altre figure autorevoli che cercano di diffondere idee, fondate sulla tradizione islamica, che tendono a minare dall’interno la comunità nazionale democratica.
Tra i numerosi esempi possibili viene citato il Direttore dell’Istituto musulmano di Londra, Kalim Siddiqui, che ha “diffuso in tutti i suoi scritti l’odio per la democrazia, la scienza, la filosofia, il nazionalismo e il libero arbitrio” (pag. 351).
L’autore conclude il capitolo con una frase che, a distanza dei molti anni passati dalla stesura del libro, rimane ancora di grande attualità: “Sicuramente l’Occidente dovrebbe dimostrarsi più convinto nel difendere i propri principi democratici, minacciati dalle minoranze musulmane che si trovano al suo interno” (pag. 354).

